Le Memorie di Gasparuccio: Il “firriato” del Pizzo
Il “Firriato” è un luogo con le mura attorno a girare (“firriare”). Corrisponde al
cosiddetto “hortus conclusus” che anticamente era vicino ad un convento o ad
un monastero. Significa quindi giardino recintato. Recintato certo, perché gli
ortaggi non amano il vento e vogliono crescere riparati.
In un paese come Cattolica ove fino all’epoca della mia infanzia non c’era il
mercato e circolava pochissimo denaro, avere un “firriato” era fondamentale.
Ogni casa di rispetto aveva il suo “firriato” dove andare a raccogliere le verdure
e dove tenere qualche gallina per le uova. I contadini poi, che erano la
stragrande maggioranza della popolazione, avevano il “firriato” in campagna e
quando tornavano la sera in paese portavano qualche masserizia. Non si andava
a “fare la spesa” ma c’era una forma di baratto. Ricordo bene che i contadini
almeno una volta la settimana andavano a farsi radere dal barbiere con cui
avevano pattuito una forma di abbonamento. Poi al momento della trebbiatura
del grano, il barbiere andava sull’aia con il suo carrettino ed andava a riscuotere
la quantità di grano che gli toccava. I barbieri a Cattolica erano produttori di
grano, avevano i loro depositi e poi vendevano ai commercianti.
In fondo alla strada in cui sorge il nostro Palazzo (la via Collegio) c’era (e c’è) un
grande portone verde che da accesso al nostro “firriato” che era davvero enorme
(certamente più di un ettaro). All’inizio c’è un piccolo pianoro accanto al quale i
miei antenati costruirono i grandi granai, enormi magazzini destinati al deposito
del frumento che veniva dai feudi. Uno di questi granai poi fu trasformato da mia
madre in un cinema. Ma questa è un’altra storia.
Dopo questo piccolo pianoro il terreno prende un andamento molto scosceso
fino ad arrivare alla parte bassa del paese. Per questo, dal suo toponimo il luogo
veniva chiamato “Il Pizzo”, cioè vetta, cima più alta della montagnola su cui era
stato edificato il paese. Ovviamente quindi era (ed è) la parte più panoramica
della zona e questa è la sua attrattiva. Lì ho creato un piccolo spiazzo dove,
quando ci siamo, mettiamo un divanetto di vimini ed alcune poltroncine e
talvolta ci riuniamo per bere un aperitivo ed assistere al tramonto con il sole che
lentamente muore nel mare. Spettacolo impareggiabile.
Il “firriato” dalla via Collegio arrivava a Via Pozzillo che era l’antica strada di
accesso al paese. La via Oreto non esisteva ancora e fu aperta soltanto negli anni
venti del novecento, spezzando in due il nostro “firriato”: la parte oltre la via
Oreto successivamente, negli anni cinquanta, ci fu espropriata per fare le scuole
(che poi furono abbandonate e trasformate nella caserma dei carabinieri), la
rimanente parte fu venduta a Nzulu Miliziano che la trasformò in un cantiere per
il calcestruzzo e deposito di materiale edile fino a quando non fu acquistata, in
anni recenti, da Autogreco.
La parte al di qua della Via Oreto è stata da me edificata negli anni ottanta con la
costruzione di garage/magazzini sulla strada in parte venduti ad Autogreco e
per la maggior parte ancora nella mia disponibilità.
In tal modo oggi l’estensione del “firriato” si è molto ridotta e praticamente
rimane il pianoro e le ampie aiole che costeggiano i vialetti e le scalinate che
portano in basso.
In antico dal “firriato” veniva a casa nostra di tutto: in primis le verdure di tutti i
tipi (c’era anche una bella carciofaia che nella stagione si presentava molto
fiorita), poi tutti i tipi di frutta: ricordo i gelsi e le enormi ficaie insieme agli
azzeruoli, alberi immensi. Poi nella parte bassa c’era un piccolo uliveto ed anche
molti alberi di mandorli ed agrumi di ogni tipo (dai mandarini ai limoni di
diverse varietà come i deliziosi limoncelli). C’era una sorgiva che alimentava un
grosso “gibbiuni” poi trasformato in pubblico abbeveratoio dove ora c’è la
caserma dei carabinieri. C’era un grande “cufularu” per mettere a bollire il
pentolone perché con la frutta prodotta mia madre faceva grandi quantità di
marmellate di tutti i tipi. Ho ancora un suo quadernone con la sua tipica
calligrafia dove venivano scritte le ricette.
Durante gli anni della guerra mia madre faceva tenere nel “firriato” anche una
mucca e due capre che la mattina qualcuno trascinava in piazza. Mia madre si
affacciava, calava un paniere con dentro un bollitore nel quale si faceva mungere
un paio di litri di latte, mentre lei affacciata alla finestra sorvegliava l’operazione
e poi tirava su il cestino e metteva il latte a bollire.
C’era anche il maiale che si “scannava” alla vigilia di Natale ed io ricordo bene il
macellaio che riempiva il grande tavolo della cucina con i pezzi di carne ed in un
angolo la macchinetta per fare le salcicce con budelli di varie dimensioni. Le
salsicce poi si mettevano appese al soffitto della dispensa. Altre parti del maiale
venivano messe sotto olio o sotto sale e poi si procedeva alla produzione della
sugna (la saimi). Si utilizzava tutto, anche il sangue per fare il “sanguinaccio” ed
alla fine c’era anche la vescica (la “bussica”) che veniva data a me che la usavo
per giocarci come un pallone un pò sbilenco.
Dal “firriato” veniva anche la legna delle potature che alimentava i nostri
“cufulari” della cucina. Infine al “firriato” si faceva anche il carbone, il sapone ed
il vino cotto nelle grandi “quadare” ancora oggi esistenti. Poi si faceva l’estratto
di pomodoro in enormi vassoi di legno da esporre al sole, che si chiamavano
“masteddri” che ancora oggi ho nel magazzino. E poi ancora la composizione di
numerose “trizzi di ficu” (cioè fichi secchi). Ed infine le galline, la chioccia con i
pulcini ed i conigli nelle grandi gabbie. C’era anche un meraviglioso pavone che
faceva la ruota. Insomma senza il “firriato” sembrava che non si potesse vivere.
Noi da bambini ci sperdevamo nella parte bassa e a volte non trovavamo più il
viottolo per risalire il dirupo. Ne ho un pauroso ricordo infantile con tutto che
viene ingigantito.
Mia madre amava molto quei luoghi ed aveva anche fatto costruire precari
vialetti, costeggiati da muretti a secco sormontati da vasi di fiori.
Successivamente anche io mi sono molto occupato del “firriato” lastricando i
vialetti con solide testette (conci di tufo) che rappresentano il pavimento e
costruendo solide mura e scalinate (sempre in testette) per aver facile accesso
nelle parti scoscese. Tornavo ogni estate a Cattolica. Dicevo ai miei amici che
avevo “il mal della pietra”. Mi guardavano preoccupati ma io spiegavo loro che
quel male non si curava negli ospedali con i farmaci ma si curava solo a Cattolica
con muratori, idraulici, elettricisti ed imbianchini. Avevo creato una piccola
squadra composta dal muratore Nino Forte con i suoi due manovali, da Saro
Mingoia, idraulico ed elettricista e da Giovanni Di Mora, imbianchino. Era
convenuto che nei tre mesi estivi avrebbero lavorato per me. Oltre al restauro
del Palazzo, avevamo sistemato le case di campagna a Cappellania ed a
Giardinelli ed ora stavamo sistemando il “firriato”, trasformando tutti i ruderi in
graziose casette date in comodato ad amici.
Mia madre aveva una concezione ancora feudale nei rapporti con chi
concretamente si occupava del “firriato”: pretendeva i prodotti (frutta, verdura,
agrumi, uova, pollame etc.) senza alcun compenso per il lavoro necessario
perché diceva che il contadino che se ne occupava ricavava moltissimo dalla
vendita dei prodotti che faceva per proprio conto. Intanto il contadino stava
dentro, aveva il possesso ed occupava anche i ruderi interni (paglialora,
porcilaia, pollaio etc.) e ci considerava come intrusi le poche volte che ci
andavamo. Insomma il “firriato” era destinato a perdersi e già parlavano di
usucapione. Era quella l’epoca della propaganda comunista con lo slogan “la
terra ai contadini”.
Ho dovuto impegnarmi con tutta la mia energia per ristabilire la situazione e
riconquistare la proprietà. Intanto di nascosto a mia madre ho stipendiato il
contadino che occupava la terra. Tutti gli anni gli mandavo un assegno con
lettera di accompagnamento con cui lo qualificavo custode e gli davo
disposizioni. Poi pretendevo la firma per ricevuta su ogni fotocopia di assegno.
Ho ancora un quadernetto con incollati una ventina di assegni inviati
annualmente a questo contadino ed alla moglie che si chiamavano Rosa Rizzuto
e Raimondo Gentile, ormai erano riconosciuti dai vicini di casa come i veri
padroni del giardino del Pizzo.
Rosa e Ramunnu avevano l’atout di abitare esattamente davanti la porta di
ingresso e potevano quindi sorvegliare con facilità, impedendo l’accesso di
ladruncoli. In quel periodo infatti uno sport molto praticato dai ragazzacci era
quello di andare a rubare frutta ed ortaggi e ricordo bene che le mura del pizzo
non solo erano sormontate da barriere di filo spinato ma nella sommità
venivano murati anche pezzi di vetro (bottiglie rotte) per impedire ai ladri di
arrampicarsi. Ora gli adolescenti sono attratti dal miele offerto dalle loro
coetanee che si concedono in modo scandaloso…. Nessuno va più a rubare la
frutta
Rosa periodicamente andava ad Agrigento, dove mia madre visse i suoi ultimi
dieci anni di vita, e portava panieri ricolmi di frutta, ortaggi ed uova fresche.
Raccontava che mia madre le diceva: “Rosa, Rosa, parlami del Pizzo”. Rosa dava
notizie e mia madre faceva domande ed insisteva: “parlami ancora del Pizzo”. E
Rosa non sapeva cosa altro dire e mia madre stava per ore ad ascoltarla, voleva
tutte le descrizioni possibili, lei che conosceva i singoli alberi e cespugli; non
avrebbe mai smesso di ascoltare Rosa che parlava del Pizzo.
Io intanto avevo iniziato una lotta corpo a corpo con Ramunnu per estendere le
piante di vegetazione mediterranea che ogni anno portavo e ridurre sempre più
la superficie dedicata alle verdure. Trovavo cavoli dappertutto. Poi ho iniziato
una politica di regolarizzazione dei confini naturali ricomprando quello che nei
secoli era stato venduto. Non ho ancora finito perché rimangono fuori dal
perimetro alcune unità immobiliari che a sono sempre pronto a riscattare.
La prima cosa che ho ricomprato è stata la casetta del custode. Dalle carte in
archivio risultava che questa unità immobiliare era stata venduta con il patto
della ricompra dal mio bisnonno Francesco quando era assediato dagli avvocati
che portavano avanti le cause (che poi ha tutte vinto). Intanto era necessaria
liquidità. Gli usurai volevano garanzie reali e la miglior garanzia era la cessione
del bene. Poi bisnonno Francesco è morto anzitempo ed io ho avuto la
soddisfazione di ricomprare quella unità che faceva parte integrante del
“Firriato”.
In quegli anni Bianca Harvey che veniva sempre nostra ospite, mi chiese se
poteva andare ad abitare in quella casa che aveva bisogno di pochi interventi
(cucina e bagno).
Ho accettato di buon grado ma per avere una situazione trasparente (ero ancora
in lotta con Rosa e Ramunnu che dicevano di aver usucapito l’intero terreno) ho
chiesto di fare un contratto regolarmente registrato. Così sono nati i “comodati”
e Bianca è stata la mia prima comodataria.
Martine è stata la seconda comodataria ed ha trasformato a sue spese la vecchia
pagliera tra le resistenze di “Ramunnu” che si vedeva definitivamente sfrattato.
Mi diceva: “e iu unni la mettu ora la paglia pi lu sceccu?”. Perché aveva un asino
con il quale talvolta andava in campagna.
Il compagno di Martine era Daniel Salem, Presidente della Condè Nast che
pubblica le riviste più note dell’editoria mondiale (Vogue, Vanity Fair, etc) e Vice
Presidente della London Synphony Orchestra, il cui Presidente era il Principe
Carlo, attuale re d’Inghilterra. Questo per dare l’idea del livello delle
frequentazioni di Daniel che per venti anni è venuto a Cattolica, per almeno una
settimana, occupando l’ex paglialora di Ramunnu, trasformata in un loft di
pregevole bellezza con la vista delle aride montagne ed il mare di fronte. Tipico
paesaggio siciliano. Credo che le più grandi soddisfazioni della mia vita me le
abbia date Daniel che apprezzava moltissimo il soggiorno a Cattolica e che
amava molto le cenette che organizzavo alla pizzeria la Rotonda dove Gasparino
(cuoco impareggiabile), quando l’avvertivo, partiva per Sciacca e tornava con
pesce fresco per il suo fantastico risotto alla pescatora. Daniel che frequentava i
più eleganti ristoranti del mondo mi chiedeva sempre di organizzare una cenetta
nella pizzeria di Cattolica che soltanto per noi cucinava piatti di pesce.
Poi è arrivato Umberto Bustamante, pittore cileno che ha ricostruito il “pollaio”,
sfrattando la contadina, ampliandolo con il locale sotto al granaio (detto “la casa
di lu prusulutu” perché abitato per tanto tempo da un fuori legge, ricercato dai
carabinieri). Bustamante era subentrato ad Anne Marie, vedova di Alighiero
Boetti le cui opere alle aste valgono oltre un milione di euro (questo per dare
l’idea dei personaggi che hanno frequentato il giardino del Pizzo). Per
Bustamante ho trasformato il vecchio cinema in atelier di pittura ed ho creato
quel bel finestrone, copiandolo da una fotografia degli studi di Piazza Donatello a
Firenze.
Infine è arrivata Nelly, sorella maltese di Bianca, che ha trasformato i ruderi
della porcilaia aggiungendo due locali che avevo comprato perché confinanti
(avevo paura che aprissero una finestra nel giardino). E questo è il quarto
comodato.
Ultima realizzazione è stata una acquisizione che ho messo in comunicazione
con il giardino creando un accesso con una apertura che tutti pensano ci sia
sempre stata; invece quell’archetto l’ho creato con le pietre trasportate dalla
Giaccusa. Mia moglie, Fiamma, si è dedicata al restauro ed all’arredamento di
questa casetta che abbiamo abitato per una stagione e ne ho un ricordo molto
piacevole. Poi è sempre stata una foresteria del Palazzo. Si chiama “casa
Fiamma”.
Nel “firriato” oltre agli ortaggi mia madre aveva fatto mettere alberi da frutta di
tutti i tipi tra i quali anche due melangoli (aranci amari) che utilizzava per fare le
marmellate. Poi nel periodo dell’abbandono e della supremazia di “Ramunnu”
nessuno raccoglieva più queste arance che cascavano per terra e Ramunnu
chiedeva sempre, invano, se poteva reinnestare quelle piante cui mia madre era
particolarmente affezionata. Quando morì mia madre e dopo i funerali si svolse
per tre giorni “lu bisitu” nel Palazzo con tutti i visitatori seduti attorno (parlando
del più e del meno), Ramunnu mi si avvicinò e mi disse: “Ora lu putemu
innnistari l’aranciu amaru?”. Mi prese un raptus e cominciai ad urlare dicendo di
no, con i presenti che non capivano cosa fosse successo. Le arance amare sono
ancora là e la prima raccomandazione che faccio al giardiniere di turno è quella
di averne la massima cura.
Dopo la morte di Rosa e Ramunnu, il giardino è stato affidato a Saro Terrasi che
veniva retribuito direttamente dai comodatari. Terrasi si è dimostrato un ottimo
giardiniere ed il Pizzo è diventato molto rigoglioso. Dopo Terrasi, emigrato a
Milano, il giardino è stato affidato ad un ex manovale di Nino Forte di nome
Ramunnu Terrasi (ancora Ramunnu ed ancora Terrasi .….) che né ha avuto
grande cura e con il costante controllo di mia moglie il risultato è stato
straordinario. Si è creato un giardino delle meraviglie ove tutti rimangono quasi
storditi per la bellezza.
Il segreto è quello di non far crescere le erbacce, togliendole subito e poi
nell’estate controllare quotidianamente il moderno impianto di irrigazione a
goccia che ho sistemato nei punti strategici.
Ormai il posto è conosciuto dai locali e spesso mi chiedono il permesso di venire
a fare fotografie in occasione di eventi come matrimoni, prime comunioni e
cresime.
Intanto tre comodati (su cinque) sono scaduti e dopo un breve e esperienza di
locazione ad amici, da quest’anno abbiamo affidato tutto a Jano Todaro per affitti
brevi, tramite piattaforme internet. Per me quel che conta non è una questione
di lucro, ma salvaguardare quel giardino che ha bisogno di costanti cure nelle
potature e nell’irrigazione estiva. Jano Todaro che conosco fin da quando era
ragazzo e, ritornato dalla Germania, aveva aperto un ristorante a Cuci Trazzera,
è un gentiluomo che tutto quello che tocca fa diventare oro perché, in questo
mondo di furbi, è una persona molto corretta con cui tutti vorrebbero avere a
che fare. Abbiamo anche scelto un nome da dare al vecchio “firriato” che si
chiamerà Eraclea Garden, cioè un nome che possa avere una attrazione per il
turismo internazionale e possa essere un elemento per una forma di turismo
culturale cui dovrebbe puntare Cattolica, rilanciando la zona archeologica di
Minoa.
Forse dovremmo costruire una piccola piscina al servizio delle tre casette ed
anche una seconda piscina per le due casette in basso. Vedremo.




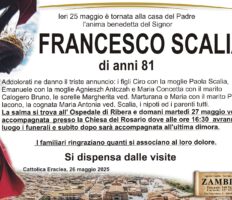
No Comment! Be the first one.